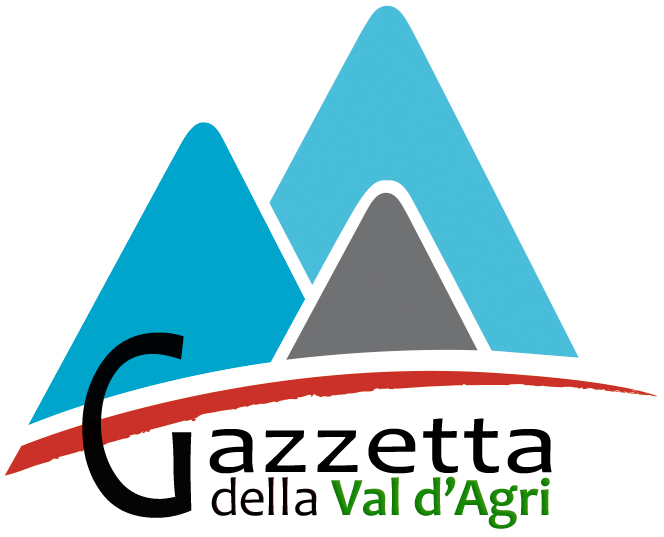Erano le 19:34, era stata una Domenica di sole, primaverile; anomala secondo gli anziani dei paesi e presagio di un qualcosa di brutto, di una calamità. Istituto Principe di Piemonte: molti erano tornati a casa per il fine settimana ed eravamo in pochi, un 30-40% dei dimoranti effettivi. Molti giocavano a ping pong nella Rotonda, una sala circolare grande e spaziosa che fungeva anche da ingresso principale. Altri passeggiavano nei corridoi ed altri ancora nella sala della Televisione a vedere la sintesi della partita domenicale Juventus – Inter, telecronaca di Carlo Nesti. Un attimo di fastidio per le sedie che si muovevano e lo sgomento della presa di coscienza che non era l’amico di seduta a scuotere la sedia ma la terra che sussultava ed ondeggiava, le porte, le altissime porte delle sale che sventagliavano come in balia di un vento senza freni, lo stridio delle mura che fa digrignare i denti come quando si scricchiolano le unghia sul ripiano di una lavagna, e la polvere che incomincia a salire dando vita a crepe vistose che si allungano e si allargano nell’intonaco delle spesse murature di pietrame del vecchio ed imponente complesso voluto, per accogliere gli orfani della guerra, da Padre Minozzi e Padre Semeria.
L’urlo di paura e lo scuro per la mancanza di luce fanno da colonna sonora agli attimi interminabili che ci accompagnano fino all’ingresso principale, dove accalcati attendiamo l’arrivo del direttore, Don Antonio Rella, che apre e libera la furia di tanti scolari impauriti e sgomenti da quel frastuono ma soprattutto dalla sensazione di mancanza di solidità per aver sentito, sotto i piedi, la terra mancare come appoggio a cui l’uomo è abituato. La corsa al buio seguendo il rumore dei tacchi di chi ci stava davanti ed accorgersi di essere arrivati oltre la fontana dell’Epitaffio senza rendersene conto. La luce torna, il rumore sembra allontanarsi come la scia di un rombo di tuono e piano piano si riprende la via del ritorno per arrivare nello spiazzo dove si odono i lamenti dei degenti dell’Ospedale San Carlo. La raccolta l’attesa per qualche amico che stava al cinema, le sirene spiegate dei Vigili del fuoco e le macchine impazzite di chi correva all’ospedale con qualche amico ferito in macchina. Poi prendere visione del dramma e capire lentamente la tragedia che ci ha reso protagonisti inconsapevoli e fortunati dei 90 secondi più lunghi della Basilicata e di tutta l’irpinia, di quella tragedia che in seguito fece dire ad Alberto Moravia, per descriverla dopo averne preso coscienza: «Ad un tratto la verità brutale ristabilisce il rapporto tra me e la realtà. Quei nidi di vespe sfondati sono case, abitazioni, o meglio lo erano». Voglio Ricordare “Calimero” (non mi sovviene il nome) di Balvano che ho rivisto dopo circa trent’anni dal Sabato 22 Novembre 1980 (lui era andato a passare il week End a casa), Clemente Paternoster che usci indenne dal cinema Ariston scampato per pochi centimetri al crollo del cornicione del Palazzo della prefettura che uccise i due sposini Potentini.
Gli amici di Pescopagano che non ho più rivisto e gli amici di Castelgrande, Angelo Troiano che da quel sabato antecedente al terremoto non ho più rivisto, e tanti altri amici e compagni che non nomino per ragioni di spazio, ma non per questo meno importanti degli altri, tutti ricordo con affetto e dispiacere per non averli più rivisti. Voglio salutare i militari che di stanza nel campo sportivo del collegio assistevano la popolazione con pasti caldi e medicinali e per ogni altra necessità. I militari che rimasero coperti di neve sotto le tende e che noi, i più robusti del collegio, andammo a liberare armati di mazze, ramazze e palette.
Ma soprattutto vorrei invitare, quelli che il terremoto lo hanno vissuto come visione di un movimento che scuote le case e le rovina per terra,a pensare che la sensazione più brutta non è vedere o sentire una protuberanza terrena che si muove come un fruscello scosso dal vento, ma il moto che rotea sotto i piedi dando la sensazione tangibile che nulla è più incerto dell’imprevedibile quando manca l’appoggio che, per antonomasia e per definizione, è ritenuto l’appoggio su cui cresce il divenire della vita e dell’evoluzione che per l’etimologia del linguaggio viene definito antropizzazione. I ns nonni, per definire un qualcosa di incerto ma di molto incerto, erano soliti dire: “manca la terra sotto i piedi”;. Ecco, questo abbiamo provato noi, protagonisti fortunati, che il 23 Novembre 1980 eravamo a Potenza alle ore19:34.