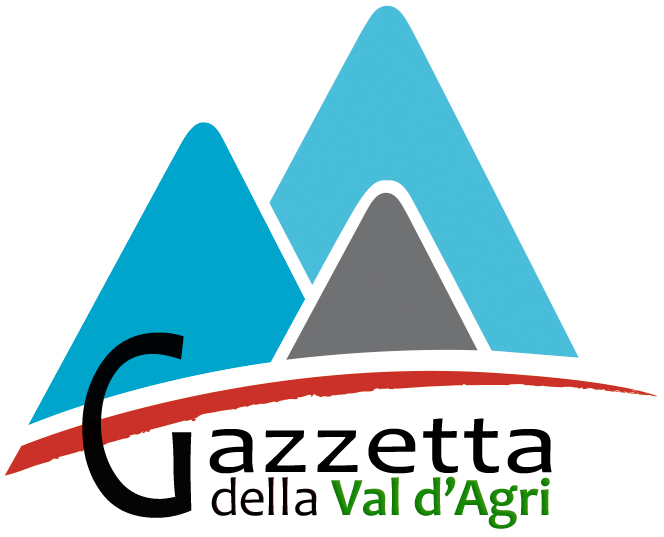Leggere l’ultimo romanzo di Giuseppe Lupo è come salire sul treno. Dopo “Gli anni del nostro incanto”, dove Lupo ci descrive l’Italia del Boom economico rivista in una Milano che correva, che si apriva al mondo e faceva sognare chi, con una tuta blu, osservava i progressi del mondo occidentale sentendosi parte di quell’avanzare a passo sostenuto verso la modernità ed una società migliore. Lupo ci riporta sull’argomento ma con una lettura che sta sulla stessa direzione e purtuttavia segue un altro verso. Perché il treno?
Perché si sale sul terno della nostra vita, nella stazione degli anni sessanta e si corre, osservando dal finestrino – in time laps – i giorni che ci hanno portato alla stazione del terzo millennio.
La delicatezza e la forbita narrazione dei periodi è penetrante, e quando arrivi a chiederti: ma mo’ di quale decennio stiamo parlando? ti arriva la risposta con un riferimento che ti riporta nella dimensione del tempo. Sia esso un brano di Kate Bush o Angelo Branduardi così come una pubblicità o uno sceneggiato televisivo o, ancora, cosa molto nota ai meridionali Lucani e Pugliesi, una proiezione mattutina di Film americani trasmessi dalla Fiera del Levante. Tutto con un confine netto e terrificante: prima e dopo il dì ventitrè del mese di novembre dell’anno millenovecentottanta.
Giuseppe Lupo ci costringe, con la delicatezza a cui ci ha abituati, a rivedere il percorso di un intero periodo che ha caratterizzato il faticoso cammino verso una emancipazione che ormai c’è ma che bisogna praticarla altrove; in un altrove cui apparteniamo senza sentirlo definitivamente nostro. Si capisce, salendo verso Milano, che le passioni possono anche avere radici e potenzialità di alto profilo ma abbisognano di campi fertili per poter dare i loro frutti. Così come è certo che qui non mancano soggetti carichi di passione ma che tuttavia, molti, sono ancora costretti a stare “altrove” per poter generare i frutti appartenenti agli obbiettivi che ognuno rincorre.
Le cose che colpiscono, almeno a me, sono l’importanza delle parole, che arrivano dopo la breve parentesi di un silenzio che assomiglia ad un indietreggiare come per voler prendere la “rincorsa”, e due frasi; una del papà che dopo quel terrificante confine del novembre 1980 disse, al termine dei novanta secondi più lunghi del Sud Italia: << ora che siamo salvi, si può raccontare>>. L’altra, quando al capolinea delle sue aspettative il protagonista dice: <<ne è valsa la pena lasciare casa!>>. Perché ancora, credo, purtroppo, varrà sempre la pena essere “altrove” per poter consentire alla terra di dare i suoi frutti.
Questo romanzo, come accennavo sopra, ha un altro verso di lettura rispetto al precedente; questa volta l’osservazione dell’Italia che cammina per rincorrere la ripresa è dal basso verso l’alto. Ma ciò non cambia alcunché rispetto alla bellezza di immergersi in un viaggio dei nostri anni e rivedere come eravamo e come saremmo potuti essere noi che siamo rimasti e quanti hanno realizzato i propri sogni andando “all’alta Italia”.
Gianfranco Massaro – Agos