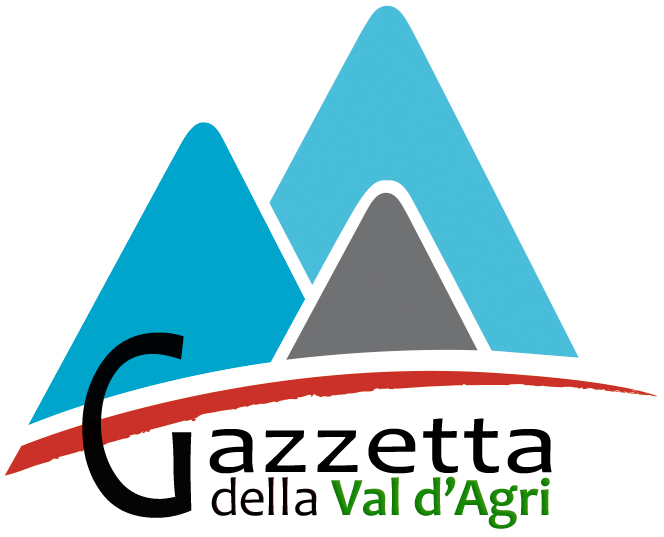“In principio dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto: proibito anche di proferire il vocabolo. Poi, febbri pestilenziali: l’idea s’ammette per isbieco in un aggettivo. Poi, non vera peste, vale a dire peste sì, ma in un certo senso; non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente, peste senza dubbio, e senza contrasto: ma già ci s’è attaccata un’altra idea, l’idea del venefizio e del malefizio, la quale altera e confonde l’idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro.
Non è, credo, necessario d’esser molto versato nella storia dell’idee e delle parole, per vedere che molte hanno fatto un simil corso. Per grazia del cielo, che non sono molte quelle d’una tal sorte, e d’una tale importanza, e che conquistino la loro evidenza a un tal prezzo, e alle quali si possano attaccare accessòri d’un tal genere. Si potrebbe però, tanto nelle cose piccole, come nelle grandi, evitare, in gran parte, quel corso così lungo e così storto, prendendo il metodo proposto da tanto tempo, d’osservare, ascoltare, paragonare, pensare, prima di parlare.
Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più facile di tutte quell’altre insieme, che anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un po’ da compatire.”
Così si chiude il trentunesimo capitolo de I Promessi Sposi. Chi non è passato per le tribolazioni di una probabile domanda su Ludovico Settala, i monatti, gli untori, i pigionai o altro che caratterizza il capitolo che ci narra la Peste del 1630; credo in tanti e mai come in questo periodo, complice anche qualche brillante iniziativa di docenti o Presidi illuminati, l’argomento sia tornato in “auge”. Mi scuserete per la banalità ma la chiusura del capitolo trentuno sembra la chiosa di un opinionista in uno dei tanti Talk Show televisivi degli ultimi giorni.
Fatto sta che, con la ciclicità che la storia delle epidemie ci ha abituati, anche quest’anno, bisestile peraltro, l’umanità deve confrontarsi con uno del più classico dei cortocircuiti della natura: una infezione che cagiona malattie e morte e che abbiamo imparato a chiamare Coronavirus. Ed in questa cornice l’uomo deve riassestare il sistema entro cui freneticamente muove i passi della civiltà. È un modo con cui la natura ci ricorda di quanto l’essere umano sia fragile e minuscolo di fronte alla grandezza del mondo e delle leggi che ne regolano la sua vita. Accidenti simili ricordano all’uomo che vi sono regole che vanno ben oltre lo scandire della campanella di Wall Street o della saracinesca che si alza per iniziare la giornata commerciale, o al turbinio delle trivelle che succhiano dalle viscere della terra la fonte per la creazione di energia che regge la macchina infernale del capitalismo. Un microorganismo può arrestare la frenesia giornaliera costringendo tutto il mondo ad un cambio di passo, che gli piaccia o no. E quando il mondo si ferma l’uomo incomincia a riflettere, come quando, in una camera ardente, tesse le lodi dell’amico per la sua prematura dipartita. Qui l’uomo riflette sulla necessità di una vita frugale, che sia vissuta con la consapevolezza che siamo di passaggio su questa terra e pertanto a che serve correre prevaricando il nostro simile in una lotta di progresso ingiustificata se poi del doman non v’è certezza? Ma la storia ci dice anche che l’uomo mostra scarsa capacità a saper utilizzare la memoria per non ripetersi negli errori che hanno determinato la sua storia.
Accennavo al Preside illuminato e nello specifico mi riferivo a Domenico Squillace, Dirigente del Liceo A. Volta di Milano, che invita i ragazzi alla prudenza ed a riflettere che rispetto alla peste del XIV e del XVII secolo oggi abbiamo la medicina dalla nostra parte e per questo a preservare il tessuto sociale e la nostra umanità; per non darla vinta alla peste. E che dire della professoressa Laura Tagliaferri della scuola media Spezzaferri di Lodi che ha invitato i suoi allievi a riproporsi nelle novelle come i dieci Novellatori di Boccaccio nel Decameron ma utilizzando le tecnologie che la modernità ci offre. E così su WatsApp è partita la Decameron challenge dove i ragazzi inventano e raccontano una Novella giornaliera dopo averne ascoltata una recitata dalla loro Professoressa e tratta dalle cento novelle dei dieci ragazzi del contado, protagonisti dell’opera di Giovanni Boccaccio.
Ora che dire, la pausa forzata a cui ci ha costretto il COVID-19 sta risvegliano virtù che avevamo dimenticato. Come gli impegni per la nostra vita e la nostra anima trascurati per via della frenesia cui siamo sottoposti dalle ferree regole di un mondo che corre. E solo quando la vita ci costringe a fermarci che riflettiamo su quello che ogni dì trascuriamo a danno della nostra anima. Mi perdonerete per la citazione ma voglio concludere questa mia riflessione con un racconto di Dino Buzzati, i giorni perduti, perché se solo fosse servito a farci recuperare umanità allora la “peste” avrà perso, e la lezione che la natura ci ha dato servirà a qualcosa:
“Qualche giorno dopo aver preso possesso della sontuosa villa, Ernest Kazirra, rincasando, avvistò da lontano un uomo che con una cassa sulle spalle usciva da una porticina secondaria del muro di cinta, e caricava la cassa su di un camion. Non fece in tempo a raggiungerlo prima che fosse partito. Allora lo inseguì in auto. Lo sconosciuto scaricò la cassa dal camion e, fatti pochi passi, la scaraventò nel baratro, che era ingombro di migliaia e migliaia di altre casse uguali. Kazirra si avvicinò all’uomo e gli chiese: “Ti ho visto portare fuori quella cassa dal mio parco. Cosa c’era dentro? E cosa sono tutte queste casse?”. Quello lo guardò e sorrise: “Ne ho ancora tante sul camion, da buttare. Non sai? sono i tuoi giorni perduti. Li aspettavi vero? Sono venuti. Che ne hai fatto? Guardali, infatti, ancora gonfi. E adesso…”. Kazirra guardò. Formavano un gruppo immenso. Scese giù per la scarpata e ne aprì uno. C’era dentro una strada d’autunno, e in fondo Graziella, la sua fidanzata che se ne andava per sempre. E lui neppure la chiamava. Ne aprì un secondo. C’era una camera d’ospedale, e sul letto suo fratello Giosuè che stava male e lo aspettava. Ma lui era in giro per affari. Si sentì prendere da una certa cosa qui, alla bocca dello stomaco. Boccheggiò. Lo scaricatore stava diritto sul ciglio del vallone, immobile come un giustiziere. “Signore – gridò Kazirra – mi ascolti. Lasci che mi porti via almeno questi due giorni. La supplico. Io sono ricco. Le darò tutto quello che vuole”. Lo scaricatore fece un gesto con la destra, come per dire che era troppo tardi. Poi svanì nell’aria. E l’ombra della notte scendeva.”
Gianfranco Massaro – Agos