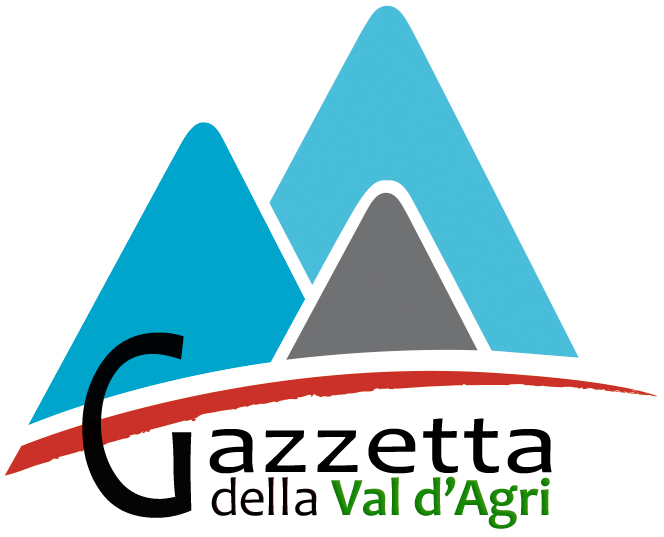La seconda parte delle proposte alla lettura, suggerite dalla nostra Collaboratrice e Curatrice di questa rubrica Aurora Alliegro, per trascorrere questo forzato isolamento alla ricerca, nei libri consigliati, di se stessi o di chi vi pare.
Per chi non avesse letto la prima parte vi invitiamo a cliccare prima a questo link, per leggere la doverosa premessa di Aurora alla sua rubrica e i primi libri consigliati, poi ritornate a questa seconda parte: la leggete e vi preparate alla terza parte e magari anche ad una quarta parte chissà…
- Nemo propheta in patria
Spesso i romanzi che più ci conquistano sono quelli degli incompresi, gli inapprezzati, coloro che vengono posti al margine e che mai verranno accettati o amati per quel che sono realmente. “Nessuno è profeta nel suo paese”, recita il Vangelo (Matteo 13,7), in altre parole coloro che ti sono più vicini, spesso, sono anche gli ultimi a riconoscere i tuoi successi, la tua grandezza, spesso appannata dalle vesti che indossi, quelle di “uomo comune” in una realtà ordinaria.
Sono numerose le storie che narrano di vite ai margini, continuamente schiacciate dal peso delle incomprensioni, dell’incomunicabilità e dei rancori più marci. Ecco le mie proposte.
Innanzitutto vorrei consigliarvi due romanzi prossimi all’omonimia, infatti invertendo il genere dell’uno, si ottiene il titolo dell’altro, e viceversa. Sto parlando, in ordine cronologico, de “Lo straniero” di Albert Camus e de “La straniera” di Claudia Durastanti.
Sebbene i titoli siano così simili, si tratta di due libri molto diversi fra loro. Il primo, pubblicato nel 1942, opera dello scrittore francese (già citato nella I parte) Albert Camus, Premio Nobel per la letteratura nel 1957, è la storia di Meursault, un impiegato che vive ad Algeri e che conduce, come tanti, un’esistenza insignificante, vittima di uno squallido conformismo. Un giorno, quasi per caso, uccide un arabo. Arrestato, egli non tenterà neppure di giustificarsi, di difendersi: non c’è spiegazione o chiarimento rispetto all’evento e al comportamento del protagonista, non si riesce nemmeno a dire chi sia veramente Mersault, se un volgare assassino, un uomo qualunque o un ribelle. L’estraniamento, nell’opera, non coinvolge unicamente la società e il sistema in cui il protagonista vive, ma persino l’interiorità di un uomo alieno a sé stesso.
La seconda proposta è un testo del 2019, finalista al Premio Strega, più vicino a noi soprattutto dal punto di vista dell’ambientazione geografica. È un testo sottilmente autobiografico, una storia che si svolge tra la Basilicata e Brooklyn, da Roma a Londra, dall’infanzia al futuro, “un’avventura che unisce vecchie e nuove migrazioni”. All’interno di una trama che ripercorre fedelmente luoghi e tappe della memoria, si muove una giovane donna capace di generare radici ovunque, in opposizione al sentimento di estraniazione forse più caratteristico della madre, la vera “straniera”. Figlia di due genitori non udenti, che al senso di isolamento oppongono un rapporto passionale ed estremo, emigrata in un paesino lucano dall’America ancora bambina, la protagonista del testo vive un’infanzia atipica, febbrile, che mette continuamente alla prova le sue capacità di resilienza. È proprio la cognizione della diversità fisica e di distinzioni sociali irriducibili, in questo quadro, a farsi risorsa e strumento di continua reinvenzione in cui il lessico, le parole, sebbene impronunciabili o inudibili, risultano momenti-chiave.
Il terzo testo consigliato è il “Mastro-don Gesualdo”, un romanzo verista dello scrittore siciliano Giovanni Verga edito nel 1889 all’interno del macro-progetto del cosiddetto “Ciclo dei vinti”. L’opera celebra abilmente il mito della “roba” (già messo in luce nell’omonima novella con Mazzarò) e al tempo stesso l’impossibilità di trasformare la ricchezza accumulata in una completa promozione sociale. Oggetto della narrazione l’ascesa sociale di Gesualdo Motta, un muratore (“mastro”) che, arricchitosi lavorando duramente, sposerà una nobildonna proveniente da una famiglia di nobiltà decaduta (diventando “don”). La scalata sociale, tuttavia, comporterà la rinuncia agli affetti più sinceri e disinteressati. È il romanzo dell’uomo alienato e solo, che tenta di emergere nonostante le resistenze sorde o esplicite della società contadina da cui proviene – che lo rifiuta per il suo modo di vivere così diverso dalla tradizionale rassegnazione – e di quella nobiliare – che non gli permette di integrarsi in un mondo in cui ha valore la nascita e non l’agire.
- Avventure e viaggi senza tempo
Spesso, nella retorica comune, filtrando inconsapevolmente uno dei temi centrali della poetica del Pascoli, si è soliti asserire che nell’animo di ognuno di noi si celi un “fanciullino”, ossia un bambino capace di volgersi al mondo con stupore, uno spirito giocondo, dedito all’azione e all’avventura, seppellito in età adulta sotto l’onerosa presa di coscienza di una realtà pragmatica e concreta. Questo “effluvio vitale”, tuttavia, riaffiorerebbe quando, casualmente o intenzionalmente, ci imbattiamo nelle storie vissute da altri, attraverso il filtro di fumetti, romanzi, racconti o anche della cinematografia.
Per coloro che si ritengono pronti a far rivivere quello spirito fanciullesco inabissandosi in avventure e viaggi senza tempo, tre sono i testi che vi suggerisco, riconducibili a generi ed epoche diverse. In generale sarebbe perfettamente attinente alla categoria scelta qualsiasi libro del celebre scrittore francese Jules Verne (ve ne cito solo alcuni dei più famosi “Dalla Terra alla Luna”, “L’isola misteriosa”, “Ventimila leghe sotto i mari” e “Il giro del mondo in ottanta giorni”), in questa sede si sceglie di proporre “Viaggio al centro della Terra”, un romanzo scientifico avventuroso pubblicato nel 1864. La seconda opera è un classico immortale della letteratura greca antica, ancora oggi oggetto di dibattiti filologici e storiografici, ovvero l’“Odissea”, un poema epico tradizionalmente attribuito ad Omero; infine un romanzo per ragazzi del 1883, il suo autore, sotto lo pseudonimo di Carlo Collodi, la definiva addirittura una “bambinata”, “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino” è un testo che ancora oggi non manca di affascinare piccoli e più grandi, celando tuttavia latenti aspetti oscuri.
La prima proposta, opera di un autore considerato precursore della fantascienza, è incentrata sul disvelamento dei misteri del centro della Terra. In seguito al ritrovamento e alla decifrazione di un manoscritto in caratteri runici contente le indicazioni per raggiungere il centro della Terra, i due protagonisti, il professore di mineralogia Lidenbrock e suo nipote e aiutante Axel, si dirigeranno, sotto strette indicazioni del testo, in Islanda. L’accesso per il centro della Terra sarebbe, secondo il manoscritto rinvenuto, il cratere del vulcano Sneffels. Tra mille insidie e pericoli, Lidenbrock e i suoi compagni di viaggio vivranno avventure al limite del possibile e dell’impossibile, per poi ritrovarsi in un oceano sotterraneo popolato da creature preistoriche. Se volete scoprire se dal centro della Terra si può anche uscire, non vi resta che leggere questo meraviglioso capolavoro!
Il secondo testo non necessita presentazioni né descrizioni. Eppure, nonostante la sua fama, sono veramente in pochi ad aver letto interamente la celebre “Odissea”, convenzionalmente attribuita a Omero. Di incerta datazione, l’opera si riallaccia al cosiddetto “Ciclo troiano” e narra le gesta dell’eroe greco Odisseo (Ulisse in latino), definito nel Proemio uomo “multiforme” o “ricco d’astuzie”, impegnato in un “nostos”, ossia in un viaggio di ritorno verso la sua patria, Itaca, dopo aver combattuto presso Troia. La fortuna dell’opera è vastissima, così come quella del suo protagonista, che riapparirà nel XXVI canto dell’Inferno dantesco con il celebre epifonema «Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza».
Pubblicato inizialmente a puntate come “Pinocchio. Storia di un burattino” sul Giornale per i bambini, poi edito in volume con il titolo “Le avventure di Pinocchio” nel 1883, l’opera destinata a divenire uno dei pilastri della letteratura dell’infanzia per la neonata Nazione italiana e per il mondo intero, nasconde una genesi e delle interpretazioni tutt’altro che limpide. Non tutti sanno, infatti, che la prima edizione a puntate del Pinocchio, non fosse stato per le insistenze del pubblico e degli editori, si sarebbe fermata al capitolo 15: Pinocchio (ancora burattino) penzola da una quercia, impiccato dal Gatto e la Volpe, non c’è speranza, non c’è redenzione, il principio di realtà trionfa su quello della fiaba. Un finale inatteso che Collodi (pseudonimo di Carlo Lorenzini) fu costretto frettolosamente a trasformare. Una gestazione tanto complessa, dunque, da indurre gli studiosi, e in particolare Emilio Garrone, a parlare di “Pinocchio uno e bino”, alludendo così alla “duplice esistenza” del Pinocchio: il primo, “uno”, ossia quello dei primi 15 capitoli, un romanzo breve e perfettamente unitario, riconducibile al Romanticismo nero e fantastico, allo stesso tempo risucchiato da quello “bino”, che prende le mosse dal capitolo primo per arrivare al 36esimo.
- Trasfigurazioni: “Totus mundus agit histrionem”
L’aforista e antiquario italiano, Alessandro Morandotti, nelle sue Minime, asseriva: “Vita come teatro applicato; teatro come vita trasfigurata”. In altre parole, il teatro rappresenterebbe la trasfigurazione letteraria della vita. La celebre massima che un tempo sovrastava il Globe Theatre di Londra – “Totus mundus agit histrionem” (Tutto il mondo recita) – confermerebbe tale pensiero. E ancora, per dirlo con le parole di William Shakespeare: «Tutto il mondo è un palcoscenico, e tutti gli uomini e le donne solamente degli attori. Essi hanno le loro uscite e le loro entrate» (As you like it, Atto II, Scena VII).
Se dovessi proporvi alcune delle “trasfigurazioni letterarie” che più ho apprezzato, certamente la triade in questione dovrebbe comprendere le seguenti rappresentazioni: innanzitutto “Sei personaggi in cerca d’autore”, il dramma più famoso di Luigi Pirandello (Premio Nobel per la letteratura nel 1934), appartenente al genere del “teatro nel teatro” (o metateatro); secondariamente un’opera associata al teatro dell’assurdo, ossia “Aspettando Godot” di Samuel Becket, Premio Nobel per la letteratura nel 1969; infine un classico intramontabile, celebrazione di inoppugnabili valori umani, sto parlando della tragedia greca “Antigone” del noto drammaturgo Sofocle.
Messo in scena per la prima volta il 9 maggio 1921 a Roma, “Sei personaggi in cerca d’autore” fece subito scalpore, dapprima incompreso e addirittura contestato (si dice che gli spettatori gridassero “Manicomio! Manicomio!”). In occasione della terza edizione dell’opera, Pirandello, per prevenire reazioni indesiderate, aggiunse una prefazione in cui chiariva genesi, tematiche e intenti del suo dramma. La trama del testo teatrale ha il suo avvio su un palcoscenico, dove una compagnia di attori prova la commedia “Il giuoco delle parti”. Irrompono in scena sei “personaggi” (un Padre, una Madre, il Figlio, la Figliastra, il Giovinetto e la Bambina) con il volto coperto da maschere. Questi, rifiutati dal proprio ideatore chiedono al Capocomico di dare loro vita artistica e di poter rappresentare la tragedia che si portano dentro (lasciata incompleta dall’autore). Nel corso della rappresentazione, oscura e angosciante, Pirandello darà vita a un esperimento ben riuscito di teatro nel teatro, in cui la struttura del dramma diventa vero e proprio tema. È una svolta meta-teatrale che disintegra lo spazio scenico portando all’abbattimento della quarta parete.
“Aspettando Godot”, rappresentato per la prima volta a Parigi nel 1953 al Théâtre de Babylon, è un dramma diviso in due atti e interamente costruito intorno alla condizione dell’attesa. Le strutture tradizionali del teatro, anche stavolta, vengono rifiutate, dando vita a una tragicommedia in cui mancano trama, personaggi (nel senso canonico del termine), azioni, ambientazione e sviluppi. Vivian Mercier, in un articolo apparso sull’Irish Times, afferma: “Aspettando Godot è una commedia in cui non accade nulla, per due volte”. Si tratta della messa in scena, costante e meccanica, di un ripetitivo e insignificante presente in cui due uomini, Vladimir ed Estragon, aspettano il misterioso Godot, allegoria di un Dio (“God”) che, nonostante la tanta attesa, non può essere conosciuto, rivelato o compreso.
Tornando al teatro nelle sue forme espressive più originarie, seppure non prive di rilevanti nodi etici, l’“Antigone” sofoclea, rappresentata per la prima volta ad Atene alle Grandi Dionisie del 442 a.C., è un’opera capace ancora oggi di porci di fronte a interrogativi di vitale importanza e di complessa risoluzione. Figlia di Edipo e di Giocasta, Antigone, dopo aver accompagnato il padre ormai cieco nel corso delle sue peregrinazioni fino alla morte (come racconta Sofocle stesso nell’“Edipo a Colono”), torna a Tebe, dove polemizza e manca di rispettare le disposizioni di suo zio, il tiranno Creonte, il quale aveva proibito di seppellire suo fratello Polinice, poiché nemico dei Tebani. Tuttavia Antigone non si arrende, seppellisce il fratello e subisce le tragiche conseguenze delle sue azioni. La sua vicenda e la sua esemplare punizione la resero nell’immaginario collettivo eroina incorruttibile in difesa degli affetti familiari, sublime esempio di pietà e fiera sostenitrice dei valori umani in costante opposizione, costi quel che costi, alla ragion di stato (tant’è che ancora oggi è usata quale metafora dei diritti del singolo contro gli Stati totalitari e in chiave anti-fascista). La tragedia rappresenta dunque il contrasto tra Antigone e Creonte, tra leggi divine e leggi umane, tra re e suddito, fra il potere politico e il privato cittadino, tra famiglia e stato.
(Continua)
Aurora Alliegro