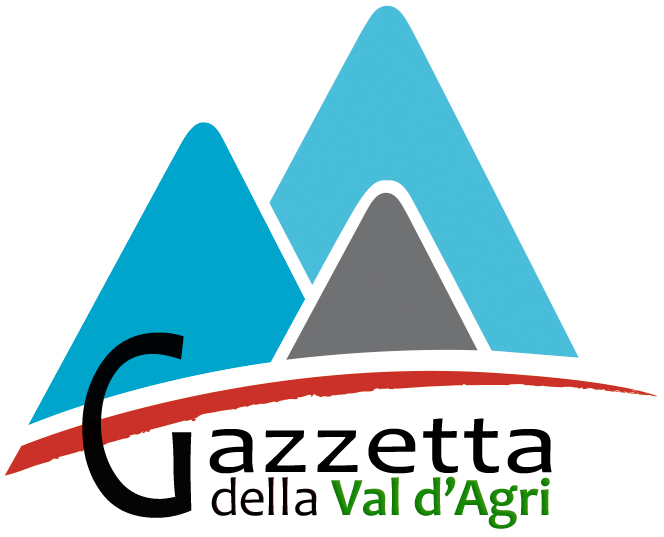U Can ra chiang (Il cane della macelleria) una storia vecchia dei nostri paesi. Quei paesi delle narrazioni di Carlo Levi dove fino ad un’epoca non tanto lontana si svolgevano pratiche quotidiane che entravano nei documentari antropologici per descriverci come popolo arretrato e lontano dalla modernità. Una di queste attività era quella del macellaio – u chianghier – che, coram populo, provvedeva a scannare l‘animale da destinare al desino giornaliero. Quivi sostava, sbavando, il cane che attendeva di poter leccare il sangue che finiva per terra. Era il cane che aveva vinto la battaglia con altri sfortunati cani privi di un “padrone” che si sarebbe occupato di sfamarli.
Uno spettacolo che si ripeteva ogni dì che il “macellaro” sgozzava questo o quell’altro animale da esporre al banco della “chianga” (la macelleria).
Di giorno in giorno siamo arrivati alle macellerie moderne, ma nel lessico quotidiano, dentro l’accezione dialettale, “u can ra chiang” resta colui che per pigrizia, o per elezione divina ma anche per esternalità negative della sua vita, vive in un contesto dove deve vincere la battaglia con altri sfortunati reietti per assurgere al ruolo di capo e poter sostare davanti all’unica possibilità di soddisfare il bisogno primario di nutrizione, sperando nello sgocciolamento verso il basso; quello che alcuni economisti chiamano Tricle – Down, ma questa è un’altra storia.
Ora, non sta qui il punto del mio ragionamento, ma nel vedere, attraverso i giornali che vi sono “macellari” magnanimi e “macellari” insensibili, ed al cospetto un branco di “can ra chiang” che si azzuffano e baruffano per poter conquistare posizioni che gli consentano di poter dare una leccata. Credo che stia anche in questo spettacolo il metro con il quale viene misurata la distanza dei giorni nostri da quelli narrati da Carlo Levi e documentati, in seguito, da De Martino nel suo lungometraggio che sintetizza il suo “viaggio in Basilicata”.
Chi governa i territori, grazie anche al vantaggio della bassa demografia, dovrebbe conoscere i profili psicoattitudinali dei suoi cittadini. Conscio pure che alcuni hanno il titolo per questione di stile o di prassi; hanno quello che volgarmente viene definito il “pezzo di carta”.
Penso, dunque, che se si vuole evitare di dare spettacolo della propria arretratezza occorre fare in modo che ognuno sia capace di poter aspirare a fare quello che ritiene opportuno per la sua vita. A chi governa il compito che ciò avvenga in un ambiente corretto, onesto e rispettoso delle regole. Togliersi dalla testa che il primo titolo per lavorare in un’industria petrolchimica sia la residenza e non la specializzazione, altrimenti avremo ingegneri non residenti che faranno i camerieri e maestri d’asilo che arroteranno saracinesche di tubazioni per l’evaporazione multiflach.
La leggerezza di certi comportamenti la si può leggere nel non vedere o non sentire lamentele, di pari enfasi, quando un avvocato sta dietro la consolle di un call center o un perito chimico fa l’autista del 118 oppure quando si vede un Diplomato d’Alberghiero che sta davanti la betoniera sotto l’impalcato di un palazzo in costruzione ed un licenziato di scuola media inferiore che fa il commiss di sala” ai matrimoni “meridionali” che si svolgono in sontuose sale “imprestate” da fattorie latifondistiche ante riforma agraria.
Occorre, a mio parere, un atto di coraggio della politica nel saper arretrare di un passo nella gestione dei fatti quotidiani e fare, invece, due passi avanti nella programmazione di un territorio che merita un futuro radioso.
I nostri giovani hanno bisogno di un ambiente sano e non del paternalismo che si maschera dietro la voglia di legalità, come quelle mamme che – in tempo di DAD – da dietro la colonna del soggiorno suggerivano la versione di greco ai figli mentre erano alle prese con la Professoressa dentro il Tablet.
Gianfranco Massaro – Agos