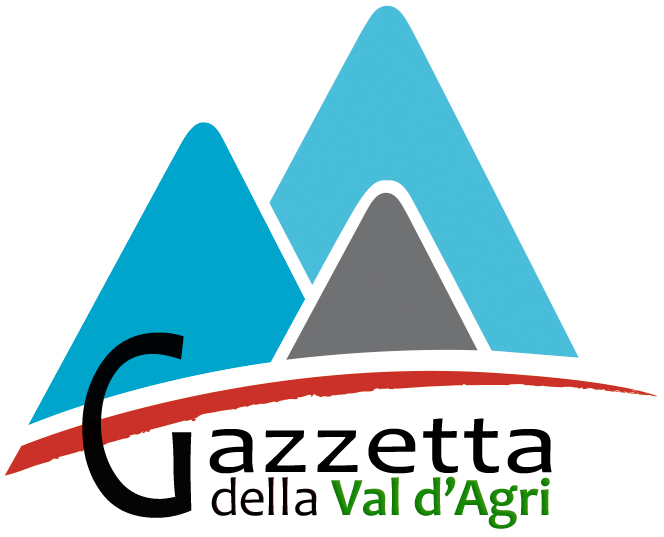“Le catene montuose sono generalmente caratterizzate da terremoti riconducibili all’attivazione di faglie che si muovono in risposta a sforzi tettonici”, spiega Francesca Di Luccio, geofisico Ingv e coordinatore, con Guido Ventura, del gruppo di ricerca, “tuttavia, studiando una sequenza sismica anomala, avvenuta nel dicembre 2013-2014 nell’area del Sannio-Matese con magnitudo massima 5, abbiamo scoperto che questi terremoti sono stati innescati da una risalita di magma nella crosta tra i 15 e i 25 chilometri di profondità. Un’anomalia legata non solo alla profondità dei terremoti di questa sequenza rispetto a quella più superficiale dell’area (meno di 10-15 chilometri), ma anche alle forme d’onda degli eventi più importanti, simili a quelle dei terremoti in aree vulcaniche”.

La prima scossa si fece sentire sui monti del Matese il pomeriggio del 29 dicembre. La magnitudo 5 (i terremoti iniziano a essere distruttivi da magnitudo 5.5) e la profondità (la scossa iniziale superava i 20 chilometri) impedirono che il sisma causasse danni significativi, anche se il tremore fu avvertito fino a Napoli. “Capimmo subito che non ci trovavamo di fronte a una sequenza tipica degli Appennini” spiega Nicola Alessandro Pino dell’Ingv, fra gli autori dello studio. “In poche ore gli ipocentri sono saliti da oltre 20 chilometri a 10 chilometri. Le scosse si sono mosse verso l’alto lungo due linee dritte, come se un fluido stesse risalendo verso l’alto ai due margini di una frattura”. E’ abbastanza frequente, nelle falde acquifere dell’Appennino, ritrovare anidride carbonica di origine vulcanica disciolta nell’acqua. “Ma terremoti come la sequenza del matese sono fenomeni sporadici”. Ed è difficile determinare se a risalire sia direttamente magma o gas che viene premuto verso l’alto dal magma sottostante. “Quello che noi osserviamo è l’anidride carbonica che risale in superficie” spiega Pino. “Di quel che si trova sotto abbiamo solo un’idea approssimativa”.
Il magma o il gas su cui preme, nelle profondità degli Appennini, hanno una pressione così forte da spaccare le rocce o da sollecitare le spaccature già esistenti, eventualmente causando terremoti normali (quelli di origine tettonica). L’anidride carbonica arriva in superficie e viene rivelata dagli strumenti dei geochimici come gas libero o disciolta negli acquiferi. “Questo risultato”, aggiunge Ventura, “apre nuove strade alla identificazione delle zone di risalita del magma nelle catene montuose e mette in evidenza come tali intrusioni possano generare terremoti con magnitudo significativa. Lo studio della composizione degli acquiferi consente di evidenziarne anche l’anomalia termica”.
“E’ da escludere che il magma che ha attraversato la crosta nella zona del Matese possa arrivare in superficie formando un vulcano”, aggiunge Giovanni Chiodini, geochimico dell’Ingv. “Tuttavia, se l’attuale processo di accumulo di magma nella crosta dovesse continuare, non è da escludere che, alla scala dei tempi geologici (ossia migliaia di anni), si possa formare una struttura vulcanica”. Durante lo studio sono stati raccolti dati sismici e geochimici e sviluppati modelli sulla risalita dei fluidi. La ricerca è iniziata con l’analisi della sismicità della sequenza del Sannio-Matese, per poi concludersi con la modellazione delle condizioni di intrusione magmatica. La conoscenza dei segnali riconducibili alla risalita di magmi in zone non vulcaniche deve essere ancor estesa ad altre grandi catene come l’Alpino-Himalayana, Zagros (tra Iraq e Iran), le Ande e la Cordigliera Nord-Americana. “I risultati fin qui raggiunti”, conclude Di Luccio, “aprono nuove strade non solo sui meccanismi dell’evoluzione della crosta terrestre, ma anche sulla interpretazione e significato della sismicità nelle catene montuose ai fini della valutazione del rischio sismico correlato”.