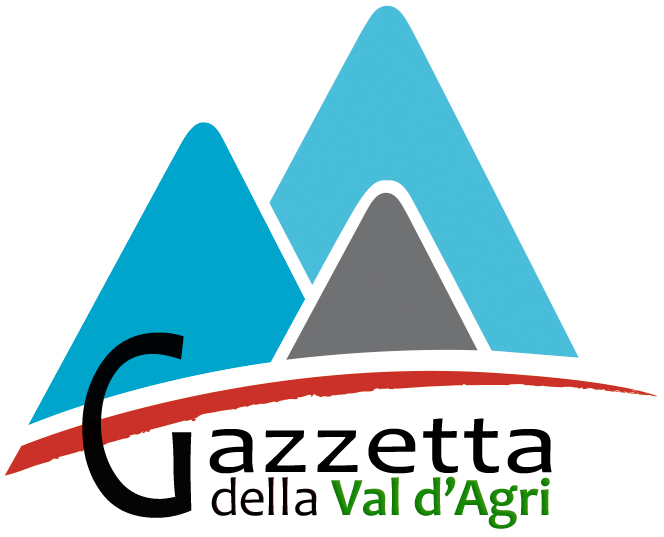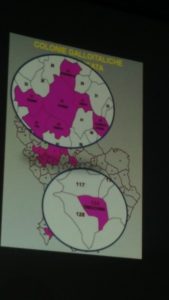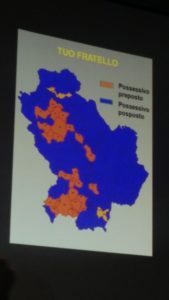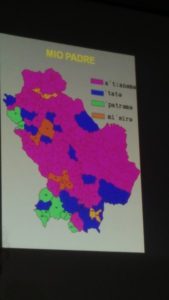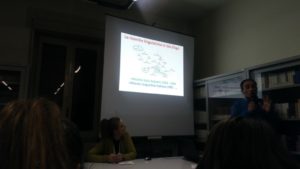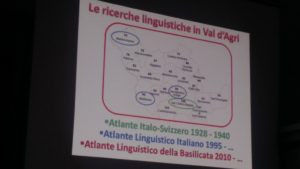Si è tenuto a Tramutola, nella biblioteca comunicale, un interessante incontro sui dialetti, da non intendere come lingue di serie B, anzi sono “Lingue” riconosciute e studiate e di cui il Progetto A.L.BA sta portando avanti uno studio tout court sul patrimonio linguistico lucano che ci appartiene e va salvaguardato.
“La lingua riflette la storia”, in Basilicata si sono avuti nel corso dei secoli influenze di popoli che hanno portato le loro lingue e i loro costumi, amalgamandosi con ciò che trovavano, e cambiando ulteriormente l’aspetto di una lingua che ci rende l’unico luogo in Italia in cui convergono tutte le peculiarità derivanti dal disgregamento del latino. Non va dimenticato per vergogna e nemmeno pulito da qualsiasi imposizione, così come non è anacronistico parlare la lingua dei nostri avi. Quella lingua che tutti noi usiamo per esprimere le “emozioni” vere come il panico, la rabbia e l’entusiasmo che solo attraverso l’uso del dialetto si riescono a veicolare e a far comprendere al meglio.
“I confini geografici non sono confini linguistici“, quando si dice:”il dialetto della Val d’Agri è quasi come il napoletano oppure il dialetto di Genzano di Lucania sembra pugliese” si sbaglia e si fa un torto alla nostra Basilicata. La Basilicata ha avuto nel corso della storia un “carattere” forte, linguisticamente parlando, e non ha subìto da nessuno la propria lingua, si sono avute delle commistioni e mescolanze questo sì, ma non è una terra di lingue imposte anzi è una terra di lingue che ha esportato alcuni termini lessicali.
“L’italiano è un’evoluzione di un dialetto“, il fiorentino all’epoca era una lingua riconosciuta ma che si parlava sono in Toscana. All’epoca, nel 1400, erano tutte lingue paritarie e non c’era nessuna differenza di valori tra le lingue parlate nella nostra penisola, non ancora va ricordato un’Italia unita. Il contesto storico ha portato a far sì che una lingua – il fiorentino – che ora viene chiamata dialetto, diventasse la lingua ufficiale in tutta Italia; quello stesso contesto storico che ha portato una lingua ufficiale dell’epoca – il veneziano – a diventare o meglio ad essere considerata un dialetto nella nostra epoca.
La Professoressa Del Puente, docente dell’UNIBAS e a capo del progetto A.L.BA (Atlante Linguistico della Basilicata), è intervenuta all’incontro snocciolando spunti di riflessione sui dialetti valligiani su cui davvero c’è da riflettere: come il genere neutro che manca nell’italiano e nei dialetti della Val d’Agri esiste; sulla particolarità dei dialetti di Grumento Nova e Viggiano, entrambi riconducibili a contatti siciliani ma avvenuti in contesti storici e linguistici differenti; l’uso del possessivo che varia così come il vocalismo differente. La docente ci ha tenuto a ribadire, come secondo lei l’insegnamento del dialetto nelle scuole primarie, potrebbe aiutare a evitare errori di grammatica in italiano, portando l’esempio dell’inglese: un bambino è consapevole che è un’altra lingua e si comporta da tale, non mischiando le due lingue; così potrebbe avvenire anche con dialetto e lingua italiana.
Sono intervenuti Annamaria Grieco, Assessore alla cultura del comune di Tramutola; Maria Rosaria Apicella, Presidente circolo culturale Ferroni; Vincenzo Lo Sasso, Presidente Pro-Loco Tramutola; due allievi della Professoressa Del Puente e Dottori di ricerca nel progetto A.L.BA Francesco Villone e Teresa Carbutti, relazionando su “Il lessico della Val d’Agri tra perdita e conservazione“; ha moderato Andrea Mario Rossi.
Gianfranco Grieco
Ignazio Buttitta in “Lingua e dialettu”
Un popolo
mettetelo in catene
spogliatelo
tappategli la bocca
è ancora libero.
Levategli il lavoro
il passaporto
la tavola dove mangia
il letto dove dorme,
è ancora ricco.
Un popolo
diventa povero e servo
quando gli rubano la lingua
ricevuta dai padri:
è perso per sempre.
Diventa povero e servo
quando le parole non figliano parole
e si mangiano tra di loro.
Me ne accorgo ora,
mentre accordo la chitarra del dialetto
che perde una corda al giorno.
Mentre rappezzo
la tela tarmata
che tesserono i nostri avi
con la lana di pecore siciliane.
E sono povero:
ho i danari
e non li posso spendere;
i gioielli
e non li posso regalare;
il canto
nella gabbia
con le ali tagliate
Un povero
che allatta dalle mammelle aride
della madre putativa,
che lo chiama figlio
per scherno.
Noialtri l’avevamo, la madre,
ce la rubarono;
aveva le mammelle a fontana di latte
e ci bevvero tutti,
ora ci sputano.
Ci restò la voce di lei,
la cadenza,
la nota bassa
del suono e del lamento:
queste non ce le possono rubare.
Non ce le possono rubare,
ma restiamo poveri
e orfani lo stesso.
UN POPOLO CHE RINUNCIA ALLA SUA LINGUA PERDE ANCHE L’ANIMA (sottotitolo) di Ignazio Buttitta poeta siciliano